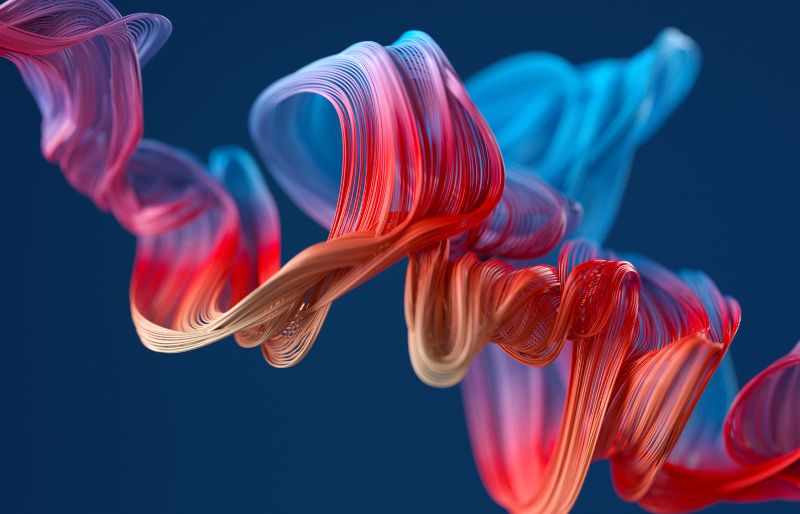
Unico socio e amministratore, l’identità con la società è lampante
Con l'ordinanza n. 17108 del 25 giugno 2025, la Corte di cassazione è intervenuta su una questione di perdurante attualità nel diritto tributario, concernente la legittimità della riferibilità a una società di capitali delle movimentazioni finanziarie rilevate sui conti correnti personali del suo socio-amministratore.
La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine da plurimi avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle entrate a una Srl e al suo socio-amministratore unico, per gli anni d'imposta 2011 e 2012.
L'ufficio, sulla base di indagini finanziarie, aveva ripreso a tassazione, quale maggior reddito d'impresa e maggior valore della produzione, importi per complessivi 1.001.000 di euro qualificandoli come ricavi non dichiarati.
Tali somme corrispondevano a significative operazioni in contante – versamenti per 331mila euro nel 2011 e 200mila nel 2012, e un prelevamento per 470mila euro nel 2011 – transitate su un conto corrente personale intestato al socio/amministratore unico presso un istituto bancario austriaco.
L'imputazione di tali movimentazioni alla società si fondava sul presupposto che, tra le varie imprese riconducibili al socio, la società accertata fosse l'unica, per volume d'affari dichiarato e per attività svolta, in grado di generare simili disponibilità liquide.
Il contribuente, per contro, giustificava le operazioni riconducendole all'attività di un'altra società, di cui era socio al 33,33% e co-amministratore, adducendo a supporto una connessione temporale tra le transazioni bancarie e alcuni accessi a una cassetta di sicurezza cointestata.
La Commissione tributaria provinciale di Trento accoglieva le ragioni della società, ma la Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige, in sede di appello, riformava la decisione, confermando la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate.
Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione.
Il contesto normativo: le indagini finanziarie e le presunzioni legali
La materia è disciplinata dall'articolo 32 del Dpr n. 600/1973, norma cardine dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria.
La disposizione, al primo comma, n. 2), attribuisce all'ufficio la facoltà di utilizzare i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, stabilendo una presunzione legale iuris tantum che si applica in modo significativamente diverso a seconda che il contribuente sia un imprenditore o un lavoratore autonomo/professionista.
La differenza più marcata, sancita da un intervento della Corte costituzionale, riguarda i prelevamenti.
Per l'imprenditore (e le società), le presunzioni operano con la massima estensione, coprendo sia i versamenti che i prelevamenti: i versamenti ingiustificati si presumono ricavi e spetta all'imprenditore dimostrare che non si tratta di corrispettivi "in nero".
Anche i prelevamenti ingiustificati si presumono ricavi.
La logica è quella della "doppia presunzione": si presume che il denaro prelevato sia servito a sostenere un costo non contabilizzato e che tale costo "in nero" sia stato necessario per produrre e vendere beni o servizi, generando a sua volta un ricavo parimenti non contabilizzato.
In sostanza, per l'imprenditore, un'uscita di cassa ingiustificata è indice di un'entrata di cassa occulta.
Per il lavoratore autonomo, l'operatività delle presunzioni è più limitata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014.
I versamenti ingiustificati si presumono compensi: la regola è identica a quella dell'imprenditore e spetta al professionista fornire la prova contraria; per i prelevamenti, invece, non opera alcuna presunzione legale. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che equiparava i prelievi ingiustificati a maggiori compensi.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo consolidato un'interpretazione estensiva di tale potere, ammettendo che l'indagine possa legittimamente spingersi oltre i conti formalmente intestati all'ente societario per attingere quelli dei soci o degli amministratori.
Tale estensione è ritenuta ammissibile a condizione che l'ufficio fornisca elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare una sostanziale riferibilità del conto o di singole operazioni alla società. Questo orientamento trova la sua ratio nella necessità di contrastare fenomeni elusivi e di evasione perpetrati attraverso la confusione patrimoniale e la fittizia interposizione di soggetti, fenomeni particolarmente insidiosi nelle società a ristretta base proprietaria, dove il controllo è accentrato e la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci tende a sfumare.
Il decisum della Corte
La suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società, sviluppando un iter argomentativo che consolida e precisa i principi esistenti in materia.
Il fulcro della decisione risiede nell'identificazione del criterio che giustifica la presunzione di attribuzione delle somme alla società. La Corte chiarisce che il fattore dirimente non è la mera qualifica di amministratore o genericamente la ristretta base sociale, bensì il cumulo, in capo alla medesima persona, delle qualifiche di amministratore unico e di socio unico.
Questa specifica situazione determina, secondo i giudici, un "controllo totale ed incondizionato" che porta a una "sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari".
In tale contesto, l'amministratore-socio può disporre del patrimonio sociale ad libitum, senza essere soggetto al controllo di altri soci o organi gestori. È proprio questa assenza di alterità tra la volontà dell'individuo e quella dell'ente a costituire l'elemento grave, preciso e concordante, che legittima l'estensione delle indagini al conto personale e la conseguente presunzione di riferibilità alla società delle operazioni non giustificate, con il correlato effetto dell'inversione dell'onere probatorio.
La Corte ha, inoltre, ritenuto irrilevante la difesa del contribuente fondata sulla società austriaca, proprio perché in essa il socio rivestiva una posizione non dominante (socio al 33,33% e co-amministratore), non replicando dunque quella situazione di controllo totalitario presente nella società accertata.
Giova sottolineare, infine, come la Cassazione abbia dichiarato manifestamente infondato il motivo subordinato con cui la società chiedeva la deducibilità del costo per i presunti compensi erogati all'amministratore. La Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento, secondo cui la deducibilità di tali compensi è subordinata a una "esplicita delibera assembleare" che ne determini l'ammontare, non potendosi considerare tale la mera approvazione del bilancio.
Conclusioni
L'ordinanza in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata, apportando tuttavia un contributo di significativa chiarezza dogmatica e pratica.
Essa eleva il "controllo totale e incondizionato", derivante dalla coincidenza delle figure di socio unico e amministratore unico, a fattore presuntivo qualificato, idoneo a giustificare l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
Per superare la presunzione dell'Amministrazione, infatti, non sono sufficienti mere allegazioni o prospettazioni alternative, ma è richiesta una prova contraria puntuale, specifica e documentata, atta a dimostrare in modo inequivocabile l'estraneità di ogni singola movimentazione finanziaria all'attività d'impresa.